
La Corte e le altre Corti
Le Corti "sorelle"
La giustizia costituzionale non è un fatto specificamente italiano. Più volte abbiamo
sottolineato che la Corte
costituzionale italiana, pur collocandosi nel quadro di precise e specifiche regole della
Costituzione della
Repubblica, ha una fisionomia e un ruolo analoghi a quelli di organi simili (Corti o
Tribunali costituzionali, Corti
supreme) presenti in altri ordinamenti, che svolgono compiti paragonabili. Si è osservato
anche che, nel suo lavoro,
la Corte non trascura l'esperienza degli altri paesi.
Da tempo si sono sviluppate relazioni di scambio e di
collaborazione con questi organi, soprattutto europei, ma anche di altre parti del mondo,
tra cui in particolare
quelli dell'area ispanico-americana, in cui la cultura giuridica italiana esercita influenza
significativa.
Le relazioni più intense riguardano le Corti costituzionali europee simili alla nostra per
storia ed esperienza (la Corte costituzionale
federale tedesca, il Tribunale costituzionale austriaco, il Consiglio costituzionale
francese, il Tribunale
costituzionale spagnolo, quello portoghese: con gli ultimi tre la Corte ha formalizzato i
rapporti con uno specifico
accordo quadrilaterale che prevede incontri annuali tra Giudici e scambi di documentazione).
In Europa opera, dal 1970, la Conferenza delle Corti costituzionali europee, che organizza,
fra l’altro, un Congresso ogni tre anni: l’ultimo, il XVII, si è tenuto a Batumi (Georgia),
dal 29 giugno al 1° luglio 2017, sul tema Il ruolo delle Corti costituzionali nel
sostenere ed applicare i principi costituzionali.
A livello più ampio opera la Conferenza mondiale sulla giustizia costituzionale,
che raggruppa più di 100 Corti di tutto il mondo, con lo scopo di promuovere la giustizia
costituzionale e la tutela dei diritti umani,
intesi come elementi chiave per lo Stato di diritto e la democrazia
(il IV Congresso si è tenuto a Vilnius dall’11 al 14 settembre 2017, sul tema Lo stato di
diritto e la giustizia costituzionale nel mondo moderno).
I rapporti fra le Corti sono agevolati anche dall’opera della Commissione per la democrazia
attraverso il diritto,
cosiddetta “Commissione di Venezia” per via della sede dei suoi lavori,
istituita dal Consiglio d’Europa col proposito di diffondere la conoscenza dei sistemi
giuridici dei diversi Paesi europei
(soprattutto, originariamente, nel processo di democratizzazione degli Stati dell’Europa
orientale),
e di studiare i problemi che possono insorgere nel funzionamento delle loro istituzioni.
Tale Commissione riserva particolare attenzione alla giustizia costituzionale,
e la nostra Corte le offre un valido contributo fondato sulla propria, ormai più che
sessantennale, esperienza.
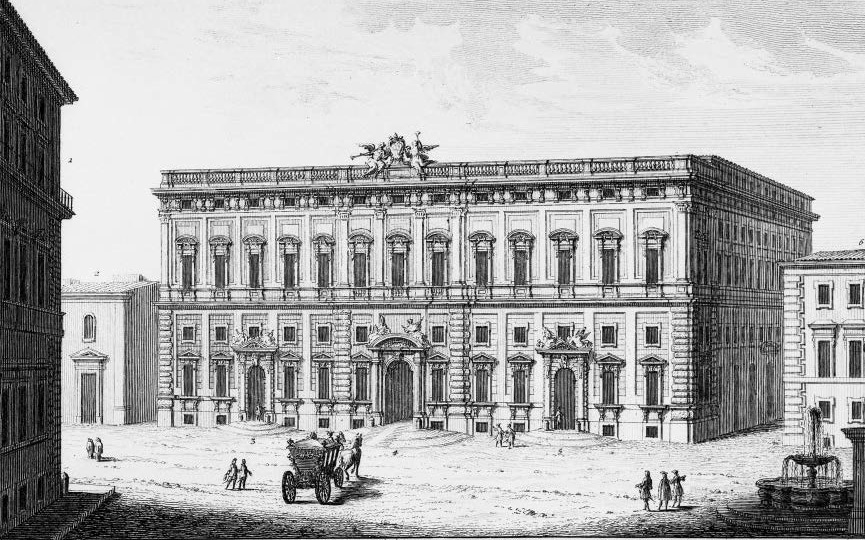
Le Corti internazionali e sovranazionali
Rapporti di collaborazione e di scambio esistono anche con le Corti internazionali che
operano in campi affini a
quello della Corte costituzionale. Così la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la
quale giudica, su istanza
anche dei singoli interessati, sulle violazioni dei diritti umani garantiti dalla
Convenzione europea del 1950 che
si verificano nell'ambito dei singoli Stati membri (oggi sono 47 Stati europei), senza che
le vie di ricorso offerte
dall'ordinamento interno dello Stato vi abbiano posto rimedio.
Poiché il contenuto dei diritti garantiti dalla
Convenzione europea non è sostanzialmente molto diverso da quello dei diritti garantiti
dalla Costituzione, la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte costituzionale affrontano
talora gli stessi problemi
(e non è esclusa anche la possibilità di contrasti fra le due giurisprudenze). La differenza
fondamentale è che la
nostra Corte si occupa solo delle leggi, per verificare se sono in armonia con la
Costituzione, mentre la Corte di
Strasburgo si occupa non delle leggi, ma di casi concreti in cui viene denunciata la
violazione di un diritto,
indipendentemente dal fatto che essa dipenda dall'esistenza di una legge o invece da cattiva
applicazione delle
leggi o da abusi od omissioni delle autorità nazionali, o da altri difetti di funzionamento
del sistema interno
(come nel caso delle frequenti denunce portate a Strasburgo per la durata irragionevolmente
lunga di processi
giudiziari in Italia). La Corte europea non può però sostituirsi alle autorità nazionali:
può solo condannare lo
Stato a rimediare alla violazione del diritto, se possibile, o a pagare una somma al
danneggiato a titolo di
riparazione. A partire dal 2007 (sentenze nn. 348 e 349), la Corte costituzionale, facendo
leva sul primo comma
dell'art. 117 della Costituzione (nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3
del 2001), dichiara
illegittime le leggi nazionali in contrasto con la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, nell'interpretazione
ad essa data dalla Corte di Strasburgo.
Un rapporto privilegiato e fruttuoso lega la Corte costituzionale e la Corte di giustizia
dell’Unione europea,
che siede a Lussemburgo e che si occupa essenzialmente degli atti delle istituzioni europee
e delle violazioni del diritto dell’Unione europea
da parte degli Stati membri.
Il diritto dell’Unione e il diritto interno degli Stati membri si incontrano e si
intrecciano oggi sempre più frequentemente e strettamente,
sicché sia la Corte dell’Unione sia i giudici nazionali sono chiamati a risolvere problemi
giuridici analoghi o addirittura coincidenti e sovrapposti.
Anche la Corte costituzionale sempre più spesso è adita per la risoluzione di questioni che
sono portate anche all’esame
della Corte di giustizia dell’Unione, specialmente da quando la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea
(approvata a Nizza già nel 2000) ha assunto il medesimo valore dei trattati, a partire dal
1° dicembre 2009.
Può quindi capitare che un giudice si trovi a dubitare della compatibilità di una legge
italiana sia con la Costituzione sia con un diritto garantito
a livello dell’Unione europea. In relazione a questa eventualità, la Corte ha recentemente
chiarito
(a partire dalla sentenza n. 269 del 2017) che vi può essere un concorso di rimedi
giurisdizionali, sia nazionali che europei.
Per favorire il coordinamento dell’azione delle varie Corti competenti l’ordinamento prevede
il prezioso strumento del «rinvio pregiudiziale»
che permette ai giudici nazionali, compresa la Corte costituzionale, di raccordarsi con la
Corte di Giustizia,
quando una specifica controversia coinvolga profili di diritto nazionale e di diritto
dell’Unione.
La prassi più recente mostra come, attraverso la migliore conoscenza reciproca e la
cooperazione internazionale delle Corti,
si rafforzano i presupposti perché gli ideali e i princìpi del costituzionalismo – diritti e
doveri della persona, equilibrio fra i poteri,
garanzie di giustizia – si affermino e si rafforzino in uno spazio che supera i confini
nazionali.
